La Dott.ssa Caterina MARIOTTI, neurologa presso l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, ha accettato l’invito dell’Associazione a partecipare all’annuale assemblea degli Associati, tenutasi il 12 aprile scorso.
“Il mio intervento oggi vuol portarvi un aggiornamento sugli studi clinici e sulle sperimentazioni farmacologiche che sono attualmente in corso presso il nostro Istituto. Partirei dagli studi clinici non-farmacologici – come ad esempio, il registro mondiale denominato Enroll-HD – che ci permettono prima di tutto di stabilire collaborazioni importanti tra medici, famiglie e pazienti e consentono di studiare in un numero molto grande di pazienti, aspetti diversi della malattia e del suo sviluppo. Simili dati possono essere di grande aiuto per progredire nella ricerca della cura: i risultati di questi studi osservazionali, che non sperimentano appunto terapie farmacologiche ma osservavo attentamente tutti i sintomi e le fasi della malattia, hanno rappresentato un motore che ha spinto avanti la ricerca in maniera molto importante.
Mentre negli anni passati l’osservazione dell’Huntington era focalizzata sul tipo di sintomi e sulla loro modalità di progressione, adesso siamo molto più interessati a cercare di capire gli aspetti che precedono l’inizio della malattia: si cerca di indagare la catena di eventi patologici che precedono la comparsa dei sintomi e che rappresentano la fase più precoce della malattia. Si studiano quindi i cambiamenti che possono avvenire a livello del sangue e le modificazioni precoci che possono essere misurate nel cervello con l’uso della risonanza magnetica.
La sperimentazione ci ha insegnato in questi anni che prima si arriva e più si può ottenere dalle terapie. La prevenzione è importante in tutte le malattie, ma particolarmente in quelle neurologiche dove è strategico poter intervenire farmacologicamente nel periodo in cui le cellule nervose possono essere più recuperate nelle loro funzione, prima che arrivino ad uno stadio in cui la neurodegenerazione sia irreversibile. Le terapie devono quindi arrivare quando le cellule pur sofferenti, sono però ancora in una situazione nella quale è possibile ripristinare la loro attività iniziale o almeno arrestare il processo neurodegenerativo.
Parliamo adesso delle sperimentazioni farmacologiche che coinvolgono generalmente un numero molto ridotto di pazienti, rispetto alla popolazione complessiva Huntington. Il gruppo interessato da queste sperimentazioni deve essere simile in tutti i centri coinvolti dallo studio, che sono chiamati a rispettare un protocollo comune per scegliere le persone da inserire che avranno caratteristiche simili per gravità, sintomi, e durata di malattia. Se è vero che non tutti possono entrare nelle sperimentazioni, è altrettanto vero che tutti poi possono beneficiare dei farmaci se le sperimentazioni portano a stabilire l’efficacia di una nuova terapia.
È importante sapere poi due cose:
- Le sperimentazioni cliniche di questo tipo sono per la maggior parte randomizzate in doppio cieco. Cosa significa? Vuol dire che in quel gruppo di pazienti molto simili tra di loro, si avranno due sottogruppi formati dalla casualità (divisi in maniera random): uno che assumerà il farmaco e l’altro il placebo, sostanza che non ha alcun effetto. Né il paziente, né la famiglia né i medici che conducono la sperimentazione sono a conoscenza di chi prende il placebo e chi prende il farmaco. È partendo dalla medesima situazione iniziale che potremo nel tempo mettere a confronto il gruppo placebo con il gruppo farmaco.
- Le fasi delle sperimentazioni sono tre.
Studio di fase I vuol dire che il farmaco è usato per la prima volta nell’uomo. Non tutti i centri e gli ospedali sono autorizzati da AIFA a condurre le sperimentazioni di questo tipo, perché sono sperimentazioni considerate ad alto rischio e quindi si possono effettuare solo su un numero piccolo di pazienti, e in centri qualificati.
Studi di fase II servono per indagare se il farmaco ha una qualche efficacia terapeutica. Viene trattato un numero medio di pazienti per circa 6 -12 mesi e si studiano i benefici e gli effetti avversi. Se un farmaco ha dato risultati positivi durante la fase II, si procede con la fase III che prevede il trattamento di un numero molto più grande di pazienti. Se questo studio conferma gli effetti positivi del trattamento, il farmaco può essere considerato dalle autorità regolatorie che decidono se può essere messo in commercio e a disposizione di tutti i pazienti.
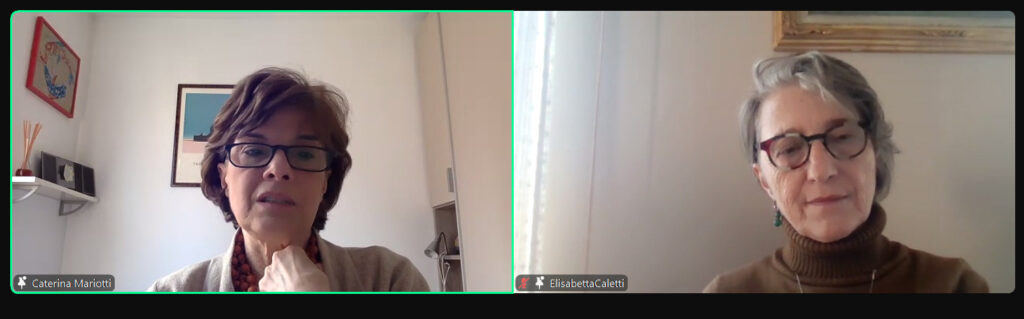
Cosa stiamo facendo al BESTA di Milano? I farmaci attualmente in studio sono due:
- Uno è una molecola di Roche, chiamata Tominersen. Questo farmaco è stato studiato ormai da almeno 5-6 anni. La molecola si chiama ASO, cioè oligonucleotide antisenso che agisce riducendo la produzione della proteina mutata che è l’Huntingtina. Il farmaco viene somministrato a livello intratecale, attraverso puntura lombare. Ve lo ricorderete sicuramente perché qualche anno fa abbiamo cominciato uno studio multicentrico internazionale di fase III che prevedeva circa 800 pazienti trattati con diversi dosaggi. Questo studio è stato interrotto prima della sua conclusione, per comparsa di effetti collaterali in pazienti trattati con il dosaggio più alto. Sembrava la fine di questa molecola, invece ci sono stati degli studi successivi sui risultati della sperimentazione. Roche ha ritenuto che la molecola potesse essere efficace, ma con un dosaggio più basso e in pazienti nelle fasi iniziali della malattia. Quindi a volte la medicina potrebbe essere giusta, ma il dosaggio sbagliato. Nelle sperimentazioni, infatti ci sono tantissimi aspetti c da tenere in considerazione, come il dosaggio, la somministrazione, le caratteristiche dei pazienti. Attualmente è in corso uno studio in doppio cieco di fase II.
- Un’altra sperimentazione è quella sponsorizzata dall’azienda PTC. In questo caso la molecola è diversa, ma il meccanismo finale è sempre associato alla riduzione di proteina mutata. Il vantaggio di questo farmaco è che il trattamento è orale e quindi l’assunzione è molto più semplice per i pazienti. Attualmente abbiamo completato la fase II in doppio cieco, e adesso tutti i pazienti che sono nello studio assumono effettivamente il farmaco e nessuno sta più assumendo placebo. Non abbiamo ancora i risultati, ma è possibile che lo studio continui con una sperimentazione di fase III, che serve per studiare gli effetti di questa molecola in un numero molto più grande di pazienti.
Roche sta studiando anche una nuova molecola, che non è mai stata usata prima negli esseri umani. In questo caso si tratta di uno studio di fase I e se si dimostrerà la sicurezza di questo trattamento si potrà passare a studi di fase II e poi di fase III.
Colgo l’occasione di questo incontro anche per sottolineare che spesso questo lavoro è caratterizzato da un certo silenzio nella comunicazione, silenzio che non deve essere assolutamente scambiato con immobilità: è importante condividere informazioni corrette che magari hanno bisogno di tempo. L’impegno per cercare la cura per questa malattia è non solo diffuso ma anche costante ed è questo il motore di quella speranza che noi, professionisti e ricercatori e voi famiglie, dobbiamo tenerci stretta.”
